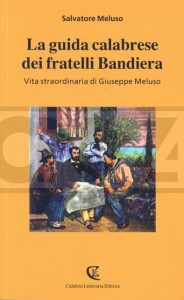Gabriele Petrone
FU GRAVE ERRORE CONSEGNARE IL GARANTISMO ALLA DESTRA BERLUSCONIANA
La fiction di Tognazzi sulla tragica vicenda di Enzo Tortora ha riportato alla memoria due figure assai importanti di quella vicenda, sulle quali vorrei fare una riflessione: Raffaele Della Valle, avvocato del presentatore che fece politica nel Partito Liberale e poi, per breve tempo, in Forza Italia, partito che contribuì a fondare salvo allontanarsene dopo breve tempo proprio in polemica con Berlusconi. Marco Pannella, leader dei Radicali, personaggio assai discusso e controverso, protagonista di importanti battaglie per i diritti civili ed individuali negli anni ’70 e ancora oggi presente nel dibattito politico.
Entrambi, come si vede, furono risucchiati dal berlusconismo degli albori proprio in nome di quella rivoluzione liberale di cui l’Italia continua ad avere bisogno.
Furono illusi dall’imbonitore di Arcore, certamente, infatti l’abbandonarono abbastanza rapidamente, ma resta da chiedersi perché andarono lì e non a sinistra. E sulla sinistra, ancora oggi, grava l’errore di non aver saputo coniugare la giusta e sacrosanta battaglia per la legalità con la difesa delle garanzie costituzionali che sono alla base di ogni vero sistema democratico.
Aggiungo un ricordo personale: era l’86 o l’87 e Tortora venne all’università a tenere un incontro; noi, i giovani comunisti dell’UNICAL, lo incrociammo e cominciammo a contestare le posizioni del radicali. Lui ci guardò e ci disse: “Voi comunisti, sulla giustizia, siete peggio dei Borboni”. Aveva ragione.
29 AGOSTO 1862: IL RISORGIMENTO FINI’ IN CALABRIA. 150 anni fa, Garibaldi veniva ferito dai bersaglieri in Aspromonte
Pubblicato su “Calabria Ora” del 29 agosto 2012
Per quelli della mia generazione, quando il il Risorgimento si studiava alle scuole elementari, era molto familiare una canzone sul ritmo della marcia dei bersaglieri che diceva “Garibaldi fu ferito, fu ferito ad una gamba…”.
Quella canzone ricorda un episodio poco frequentato dalla agiografia risorgimentale e che accadde proprio in Calabria il 29 agosto del 1862 sull’Aspromonte. Significativo il fatto che l’unica ferita piuttosto grave in decenni di scontri in ogni parte del globo, il famoso Eroe dei Due Mondi la prese per un colpo sparatogli dai bersaglieri di quella nuova Italia che proprio lui aveva tanto contribuito a costruire in decenni di battaglie e con la straordinaria impresa dei Mille di appena due anni prima.
Ma come si giunse a questo scontro a fuoco che simbolicamente suggella la fine del Risorgimento e l’inizio della travagliata storia del nuovo Stato italiano, episodio ben ricostruito nel suo splendido film “Noi credevamo” dal regista Martone ?
Il Regno d’Italia era stato proclamato il 17 marzo del 1861 dal Parlamento di Torino dopo più di quarant’anni di moti, rivolte e guerre. Decisivo era stato il compromesso tra democratici e moderati, con l’accettazione da parte dei primi della formula monarchica con a capo Vittorio Emanuele II di Savoia ”purché l’Italia, finalmente, si facesse davvero”.
Garibaldi era stato il principale fautore di questo accordo in polemica con l’intransigenza di Mazzini, consapevole che solo la forza militare del piccolo stato piemontese, l’unico dotato di un vero esercito e ormai schierato sul terreno liberale (Vittorio Emanuele non aveva revocato, nonostante le pressioni austriache dopo la sconfitta del 1848, lo Statuto concesso dal padre Carlo Alberto), avrebbe potuto realizzare il sogno di una Italia libera e unita dalle Alpi alla Trinacria, come si diceva allora.
E nel biennio 1859-1860 il sogno per i quali tanti erano morti e avevano patito anni di prigione e di esilio comminati dagli autoritari stati preunitari (per i quali certo neonostalgismo da operetta appare davvero ridicolo) la combinazione della vittoriosa guerra contro l’Austria con l’appoggio delle armate francesi di Napoleone III e della straordinaria impresa garibaldina contro il Regno delle Due Sicile, consentì di proclamare il Regno d’Italia. Mancavano però ancora il Veneto, il Friuli e il Trentino, rimasti sotto la corona austriaca, e Roma e il Lazio, rimasti sotto il dominio temporale di papa Pio IX ma, soprattutto, sotto la protezione dell’imperatore francese che non intendeva perdere l’appoggio dei cattolici francesi.
Del resto Roma rappresentava per tutto lo schieramento liberale ed indipendentista italiano un obiettivo prioritario. Senza Roma capitale, l’Italia non ci sarebbe mai stata davvero.
Lo stesso Cavour, primo artefice dell’alleanza con la Francia e Napoleone III, aveva fatto proclamare dal Parlamento “Roma capitale” come obiettivo fondamentale del processo unitario italiano già nel marzo del 1861, pochi mesi prima della sua prematura scomparsa.
Per i democratici e Garibaldi Roma rappresentava poi il simbolo stesso della lotta risorgimentale, il sogno della loro gioventù quando nel 1849 avevano proclamato e diretto (Mazzini politicamente e Garibaldi coprendosi di gloria combattendo conto le armate francesi) la straordinaria, anche se breve, esperienza della repubblica romana.
Fosse stato per Garibaldi dopo aver sconfitto i borbonici sul Volturno nell’ottobre del 1860 l’impresa dei Mille avrebbe dovuto proseguire fino alla liberazione di Roma, ma fu Vittorio Emanuele II a fermarlo, su pressione di Cavour che temeva una guerra con la Francia e un terremoto nella politica europea del tempo.
Due anni dopo, siamo nel giugno del 1862, Garibaldi decide di lasciare Caprera e andare in Sicilia. Le cose non vanno bene per il giovane Stato. Praticamente tutto il Mezzogiorno continentale è percorso da una vera e propria guerra civile, il brigantaggio, contro il quale è schierato un terzo degli effettivi dell’esercito italiano in una lotta senza quartiere.
Eppure Garibaldi è accolto con grande entusiasmo in Sicilia e ben presto attorno a lui si radunano circa 2000 volontari armati, pronti a rinverdire le gesta della spedizione dei Mille. Risuona nell’isola il grido: “Roma o morte” e il fascino dell’Eroe dei Due Mondi diventa ancora una volta il catalizzatore di speranze di vario tipo, non ultime quelle di riscatto sociale e di eroica ripresa dell’iniziativa democratica di fronte al grigiore conservatore dell’Italietta savoiarda e “piemontese”.
Il governo, presieduto da Urbano Rattazzi è attonito, incerto. Lascia i suoi funzionari periferici per il momento senza ordini. La cosa più logica sarebbe fermare Garibaldi, magari farlo arrestare prima che faccia danni e provochi una guerra con la Francia. Napoleone III tempesta le cancellerie italiane di messaggi preoccupati e minacciosi. Il re Vittorio Emanuele II è costretto ad intervenire con parole che sanno di sconfessione, contro certi imprudenti iniziative.
Ma Garibaldi non ne tiene conto: già due anni prima Cavour chiedeva che lo si fermasse e Vittorio Emanuele gli scriveva due lettere, una con la quale gli chiedeva di obbedire al Primo Ministro e una con la quale lo invitava a proseguire nella sua impresa e sbarcare in Calabria. L’atteggiamento dell’esercito e della marina sembrano dare ragione a Garibaldi: in Sicilia è lasciato indisturbato nella sua opera di reclutamento e di raccolta delle armi, gli lasciano requisire due battelli per la traversata dello Stretto e solo quando è ormai sbarcato a Melito Porto Salvo, lo stesso posto di due anni prima, gli tirano un paio di cannonate, ma senza troppa convinzione.
Garibaldi si dirige verso l’Aspromonte dove lo raggiungono altri volontari tra cui calabresi, popolani e contadini che continuano a vederlo come “portatore di riscatto, punitore di quegli avversari di classe che avevano tradito entrambi” (A. Placanica, “Storia della Calabria”, Roma, Donzelli, 1999, p.343).
A questo punto, però, il governo interviene: manda contro i garibaldini un distaccamento di bersaglieri comandati dal colonnello Emilio Pallavicini, un tipo “tosto” disponibile anche a sparare contro un monumento nazionale se le circostanze lo avessero richiesto.
Ed è sulla montagna calabrese che i bersaglieri, circa 3500, intercettano i garibaldini. Nonostante Garibaldi avesse dato ordine di non sparare e di non rispondere al fuoco per non fare la guerra contro fratelli, lo scontro ci fu ugualmente e provocò 12 morti e 34 feriti. Lo stesso Garibaldi, che si era fatto avanti forse sperando che alla sua vista i bersaglieri si unissero a lui, fu raggiunto da due colpi, uno all’anca e l’altro nella caviglia che gli provocò una brutta ferita che lo costrinse a mesi e mesi di immobilità.
Si chiudeva, così, nel peggiore dei modi, un episodio assai controverso della nostra storia, con i bersaglieri italiani, un simbolo del nostro Risorgimento, che sparavano contro i garibaldini e il loro capo, altri simboli della nostra epopea nazionale.
Il governo Rattazzi finì nelle polemiche per le sue incertezze inziali e dovette dimettersi, molti funzionari persero il posto, mentre Garibaldi fu rinchiuso nel penitenziario di Varignano, da cui uscì nell’ottobre di quell’anno per effetto dell’amnistia concessa dal re in occasione delle nozze della figlia di Vittorio Emanuele con il re del Portogallo. Una comoda via d’uscita, perché lo Stato italiano non poteva certo permettersi di tenere in prigione troppo a lungo il suo più grande eroe, noto in tutto il mondo.
Un episodio triste, che vide contrapposti ancora una volta gli ideali alla ragion di Stato, il cuore alla ragione. Per la cronaca, dopo un altro sanguinoso tentativo fatto da Garibaldi nel 1867 nella battaglia di Mentana, dove fu sconfitto da francesi e pontifici armati di modernissimi fucili a retrocarica, Roma sarà liberata dai bersaglieri solo nel 1870, dopo la sconfitta di Napoleone III a Sedan ad opera dei prussiani.
Garibaldi, da generoso qual’era, andrà a combattere la sua ultima guerra, ormai anziano e afflitto dall’artrite, proprio in difesa della neonata III Repubblica francese contro i prussiani dimostrando ancora una volta che per lui, la libertà dei popoli era un valore da difendere sempre e comunque, al di là delle convenienze e delle “ragioni di stato”.
Giuseppe Meluso, la guida calabrese dei fratelli Bandiera. Il nuovo libro di Salvatore Meluso.
Pubblicato su Calabria Ora del 9 giugno 2012
E’ appena uscito per i tipi di “Calabria Letteraria” l’ultimo saggio di Salvatore Meluso dal titolo La guida calabrese dei fratelli Bandiera. Vita straordinaria di Giuseppe Meluso.
Salvatore Meluso (San Giovanni in Fiore, 1926) non è nuovo a questi studi, anzi si può dire senza tema di essere smentiti, che molti dei punti ancora oscuri della presenza in Calabria della sfortunata spedizione dei due fratelli veneziani, sono stati chiariti proprio grazie al lavoro minuzioso e certosino negli archivi di Napoli, Catanzaro e Cosenza di questo attento ricercatore.
Il libro di Meluso ci dimostra, infatti, come spesso siano proprio le cose più evidenti ad essere quelle meno conosciute e più facili alle manipolazioni successive. In particolare Salvatore Meluso si è soffermato sulla figura della guida calabrese della cosiddetta “banda degli esteri” capeggiata dai due fratelli veneziani, quel Giuseppe Meluso, sangiovannese esule a Corfù, che si aggregò alla spedizione con funzioni di guida, l’unico a sfuggire alla cattura dopo l’agguato alla Stragola.
Questo personaggio, certamente assai complesso e contraddittorio, era scappato nell’isola greca sin dal 1834 per sfuggire a condanne per reati di “brigantaggio”, mettendosi al servizio di altri fuoriusciti calabresi sempre per reati comuni, i fratelli De Nobili di Catanzaro.
L’isola ionica, all’epoca protettorato inglese era, inoltre, il rifugio privilegiato degli esuli politici italiani dopo i falliti moti del 1830-31, ed è qui che giunsero Attilio ed Emilio Bandiera dopo aver disertato dalla marina austriaca, qui che reclutarono proprio tra questi esuli (un campionario di tutta l’emigrazione politica italiana come scrive efficacemente Lucio Villari) i 19 partecipanti alla loro spedizione in Calabria.
La spedizione, com’è noto, fu organizzata con grande improvvisazione, senza grandi precauzioni di riservatezza e nonostante il parere contrario di Giuseppe Mazzini e del suo fiduciario a Malta Nicola Fabrizi, per fornire sostegno al moto del 15 marzo 1844 di Cosenza, facilmente sedato dalle autorità borboniche e finito con alcuni morti sulle strade e centinaia di arresti, di cui, però, alcuni giornali stranieri avevano riportato la falsa notizia del successo.
Come guida la scelta cadde su Giuseppe Meluso, a quel tempo molto amico di Giuseppe Miller, un rivoluzionario forlivese, che lo presenta ad Attilio ed Emilio Bandiera i quali lo aggregano alla spedizione perché conoscitore dei luoghi.
Il libro di Salvatore Meluso ricostruisce con dovizia di particolari, desunti da una conoscenza minuziosa dei documenti di archivio oltre che della sconfinata bibliografia sull’argomento, le complesse vicende che caratterizzarono la vita di questo oscuro e bistrattato personaggio calabrese, del suo prezioso e leale contributo alla spedizione dei Bandiera, della sua feroce eliminazione nel corso di una manifestazione che richiedeva l’accesso alle terre demaniali nel 1848, eseguita con lucida determinazione da quelle stesse persone che, premiate generosamente per la cattura degli “esteri” alla Stragola da re Ferdinando II, si erano “riciclati” come liberali e “repubblicani” in quelle convulse giornate dell’”anno delle rivoluzioni”.
La storia cioè dei soliti “gattopardi”, fedeli sudditi del Borbone e poi “intransigenti liberali” a seconda del mutare del vento. E in mezzo la vicenda di quest’uomo, emigrato a Corfù per reati comuni e conquistato all’idea dell’Unità d’Italia, della libertà e della democrazia per la sua frequentazione di altri esuli “politici”e dall’esempio di eroismo dei Bandiera e dei loro compagni che guidò in un territorio ostile rischiando insieme a loro la propria vita e scontando lunghi anni di carcere duro dopo la sua consegna. Un uomo che, tornato al suo paese dopo il carcere, si mise a capo della rivolta contadina per rivendicare l’antico diritto alla terra e morì gridando: “viva la Repubblica”. Un uomo che dopo la sua morte fu sottoposto anche al ludibrio della memoria da parte di quegli stessi che per la cattura dei Bandiera avevano ottenuto lauti compensi, pensioni ed onori dal Borbone i quali, al fine di “rifarsi una verginità politica” con i nuovi governanti, diffusero la falsa notizia, ripresa da certa vulgata risorgimentale postunitaria, che a catturare i Bandiera fu il popolo minuto di San Giovanni in Fiore, impaurito dall’arrivo di una banda di briganti “turchi” capeggiati dal famigerato “Nivaro” (il soprannome assegnato al Meluso).
Nulla di tutto ciò: i Bandiera ed i loro compagni furono assaliti e catturati dalla Guardia urbana di San Giovanni rafforzata dagli uomini armati al servizio delle famiglie più importanti, notabili e proprietari terrieri, del paese silano.
Un libro prezioso, dunque, che mette nuova luce sul contributo niente affatto trascurabile della Calabria al Risorgimento nazionale e la cui lettura smentisce ulteriormente, se ce ne fosse ancora bisogno, la recente vulgata di un Mezzogiorno non solo indifferente ma addirittura ostile al processo di unificazione di cui abbiamo celebrato da poco il 150° anniversario.
SE QUALCUNO DICE “TORNIAMO ALLA LIRA” CHIAMO LA NEURO…
Tra le tante emerite stupidaggini che si leggono qui e là da parte di gente che gioca a chi la spara più grossa c’è, in queste ore, l’idea che la Grecia potrebbe uscire dall’euro senza grandi contraccolpi, anzi guadagnandoci.
Non c’è bisogno di essere economisti per capire che, se la Grecia dopo le elezioni di giugno, dovesse decidere di uscire dall’euro e tornare alla dracma sarebbe un disastro soprattutto per i greci, per tutta una serie di ragioni:
1. fuga di capitali. E’ bastata la sola notizia del fallimento delle trattative per un governo che onorasse gli impegni europei della Grecia per provocare l’uscita da quel paese di 700 milioni di euro. Non soltanto i soliti cattivi speculatori che mettono al sicuro i soldi ma anche gente semplice, piccoli risparmiatori preoccupati che il ritorno alla dracma svaluti i propri conti. Sono infatti già pronte per essere varate misure che impediscano prelievi dai conti superiori alle 50-100 euro giornalieri, giusto per le necessità quotidiane.
2. Mancanza di liquidità. Il 1 luglio lo Stato greco non avrà più i soldi per pagare stipendi e pensioni e sarà difficile che possa ottenere prestiti avendo rifiutato di onorare gli impegni assunti in precedenza per la semplice ragione di economia elementare che nessuno presta soldi a chi non è palesemente in grado di poterli restituire, anche in un futuro lontano.
3. Necessità di stampare nuova moneta. Tornare alla dracma significherà, per una semplice ragione pratica, stampare nuova carta moneta con un valore nominale di 1 dracma-1 euro, con la stessa tiratura di moneta metallica e moneta cartacea, anche per non dovere aggiornare tutti i programmi delle banche, dei bancomat, dei registratori di cassa, ecc.. Una operazione costosa di per sé. In caso di uscita dall’euro un venerdì sarà messa in circolo la nuova moneta che il lunedì successivo varrà, se va bene, il 30% in meno (alcuni stimano addirittura il 60%). Le conseguenze sull’inflazione, l’aumento dei prezzi e la perdita del potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni sono facilmente intuibili.
4. Importazioni. Il costo delle merci e delle risorse che la Grecia importa (molte) crescerebbe all’improvviso in proporzione alla svalutazione della moneta e anche più con evidenti effetti sull’aumento generalizzato dei prezzi (e quindi ancora più inflazione).
5. Esportazioni. Le esportazioni, poche, in verità, della Grecia, ci guadagneranno, sempre che le imprese greche riescano a sopravvivere al fallimento delle banche ed al generale aumento dei prezzi (cosa assai improbabile visto il contesto). Qualche effetto positivo, ma evidentemente assai limitato, si potrà avere nel turismo, sempre che la tensione sociale che inevitabilmente esploderà in quel paese a causa dell’aggravarsi della crisi economica non scoraggi anche questa possibilità.
Insomma, questo è lo scenario che si prepara per i greci. Se qualcuno lo propone anche per l’Italia io personalmente chiamo la neuro…e voi ?
IL VERO COLPEVOLE…

CLAMOROSO !!!
Finalmente lo abbiamo scoperto. E’ lui il grande vecchio, l’oscuro che trama nell’ombra, il responsabile di tutti i problemi d’Italia, della mafia, della ndrangheta e della camorra, l’artefice della discesa in campo di Berlusconi, quello che sta dietro al problema della monnezza di Napoli e del mare sporco in Calabria. Si, è proprio lui, il malefico, geniale, imprendibile CATTIVIK !!!
Enza Bruno Bossio: “Assolta perché innocente, non innocente perché assolta”

“Finalmente sono uscita da un incubo”. E’ quanto afferma, in una nota, Enza Bruno Bossio sulla conferma in appello della sentenza di assoluzione nel processo Why Not. ”Un incubo – aggiunge – che aveva provato a distruggere la mia vita e quella dei miei figli. Al quale ho resistito non solo con la consapevolezza di non aver fatto mai nulla di illecito, ma anche grazie all’affetto di moltissimi amici. Non mi sono mai sottratta ai processi in tribunale, anche se vivevo fino in fondo l’ingiustizia morale e materiale di quello che mi stava accadendo. Ma nonostante tutto ho avuto fiducia nel compimento dell’azione della magistratura, soprattutto di quella giudicante. Anche perché non mi sento di essere innocente perché assolta, ma assolta perché innocente. Dunque esiste il merito dei processi che si svolgono nelle aule dei tribunali, che sono altra cosa dei processi mediatici che condannano le persone sulla piazza prima ancora di essere giudicate da chi è preposto a questo compito”.
Enza Bruno Bossio è felice. La giustizia, quella vera, quella dei processi che si svolgono nella sola sede preposta dal nostro ordinamento, ha detto definitivamente la parola fine sulla sua vicenda giudiziaria iniziata nel 2006 dall’allora PM Luigi De Magistris.
Sono stati anni terribili in cui è stata messa alla gogna, condannata nelle piazze e sui media, messa alla berlina senza alcuna possibilità di contraddittorio secondo le regole del cosiddetto “processo mediatico” e della “macchina del fango”.
Una carriera brillante stroncata da una macchina infernale, accuse assurde che la mettevano al centro di un fantasioso teorema accusatorio che, tra l’altro, arrivò fino a Prodi e a Mastella e fu una delle cause della fine del governo dell’Unione.
L’inchiesta “Why not” oggi si sta rivelando per quella che è: un enorme, colossale flop, l’ennesimo per un PM che nella sua carriera non è mai riuscito a far condannare nessuno, ma che è stato invece abile nel costruire la sua immagine che gli ha consegnato una carriera politica prima come parlamentare europeo poi come Sindaco di Napoli.
Enza Bruno Bossio oggi è felice, ma quanto ha sofferto in questi anni difficilmente verrà cancellato. Né ci saranno trasmissioni televisive e articoli di giornale che daranno altrettanto spazio alla sua certa ed accertata innocenza come invece era stato fatto per dimostrare la sua “presunta colpevolezza” ed incensare il suo improbabile ed improvvisato Torquemada.
E’ questa la nota più amara di tutta questa vicenda e che ci dice, ancora una volta, come il sistema informativo e mediatico che ruota attorno alla giustizia italiana evidentemente non funzioni.
Fascismo e antifascismo a Cosenza. L’omicidio di Paolo Cappello.
Pubblicato su “Calabria Ora” di venerdì 16 marzo 2012.
Contrariamente a quanto certa vulgata, anche storiografica, racconta, l’avvento del fascismo in Calabria fu tutt’altro che semplice e “indolore”. Pur non raggiungendo i livelli di mobilitazione contro gli oppositori politici caratteristici di altre parti d’Italia, lo squadrismo fu presente anche nella nostra regione collezionando la sua bella sequela di intimidazioni, aggressioni e crimini.
Tra questi l’omicidio di un giovane operaio socialista cosentino, Paolo Cappello. Trovatello, come si diceva allora, sposato senza figli, di professione muratore, aveva inizialmente aderito al Partito repubblicano per poi passare ai socialisti. La sera in cui fu ucciso tornava da una riunione del direttivo della sezione “P.Rossi”. Militante attivo, arrestato qualche tempo prima e fatto liberale proprio dalla difesa di Mancini, era amato da tutti i suoi compagni e particolarmente odiato dai fascisti proprio per questa ragione. Insieme a Nicola Adamo, un altro muratore socialista (nonno dell’attuale consigliere regionale) che fu aggredito la stessa sera proprio nel tentativo di andare a soccorrerlo, erano tra i più attivi nel lavoro di propaganda e pronti ad accorrere al richiamo dei loro compagni aggrediti (questa circostanza ha fatto pensare che l’agguato di quella sera fosse premeditato e non casuale).
Siamo nel settembre del 1924. Benito Mussolini siede alla Presidenza del Consiglio da quasi due anni, ma è tutt’altro che tranquillo. Siamo, infatti, nel pieno della crisi seguita al delitto del deputato socialista unitario Giacomo Matteotti, assassinato a Roma dopo la sua vibrante protesta in un memorabile discorso alla Camera il 30 maggio, con il quale aveva denunciato le violenze e le intimidazioni che avevano caratterizzato la campagna elettorale per le elezioni del 6 aprile chiedendone l’invalidazione. Le chiare responsabilità nel delitto del gruppo dirigente più ristretto del fascismo e dello stesso Mussolini, avevano scatenato una ondata di indignazione nell’opinione pubblica e la vibrata protesta delle opposizioni che decidevano di ritirarsi dal Parlamento sull’Aventino per segnare l’illegittimità di una maggioranza e di un governo colpevoli di tale atto nella speranza di un intervento del re Vittorio Emanuele III che, com’è noto, non avvenne, aprendo la strada all’instaurazione della dittatura e alla messa fuori legge di tutte le opposizioni.
In quel clima rovente lo squadrismo aveva ripreso vigore in tutto il Paese. A Cosenza, dove socialisti e comunisti avevano eletto per la prima volta i loro deputati (Pietro Mancini e Fausto Gullo, la cui elezione fu però annullata dalla giunta per le elezioni e i resti assegnati in maniera del tutto arbitraria al popolare Nicola Siles), aggressioni ed intimidazioni si succedevano in un crescendo sempre più drammatico e violento.
In città era attiva una squadra di camicie nere, La Disperata, comandata da Nicola Zupi, che si era resa protagonista di numerose azioni contro esponenti ed organizzazioni della sinistra. L’anno prima era stata bruciata la Camera del Lavoro in Largo Vergini. Tra la primavera e l’estate del 1924 si erano succedute numerose aggressioni ad esponenti socialisti, comunisti e repubblicani nei pressi del rione Massa, il cuore “rosso” e operaio della città. Persino una festa popolare in piazza del Carmine (l’odierna Piazza Matteotti) e un concerto musicale a Donnici erano stati l’occasione di scontri, agguati e bastonature.
“La Parola Socialista”, che all’epoca era stampata con una tiratura di 3000 copie, era stata sequestrata da due militi fascisti e bruciata pubblicamente in Piazza Prefettura. Il tutto avveniva, secondo un copione comune in tutta Italia, con la sostanziale connivenza delle autorità di PS, che spesso arrestava le vittime e non gli aggressori con il pretesto della “provocazione sovversiva”.
La sera del 14 settembre, una domenica, la squadra fascista, diretta ancora una volta verso la Massa, intercettava all’altezza delle scalinate che danno sul Ponte di San Francesco (via Sertorio Quattromani) un gruppo di operai a loro ben noti come attivisti di sinistra e li faceva oggetto di numerosi colpi di rivoltella. Riporto da questo punto in poi, l’articolo de “La Parola Socialista” dovuto alla penna di Pietro Mancini: “gli aggrediti retrocedettero mentre qualcuno degli aggressori girava pel vicolo dei Casciari allo scopo, evidentemente, di imbottigliare gli operai. Nel contempo, un nostro compagno, – Paolino Cappello – solo ed inerme anche lui, ritornava a casa. Quando fu nei pressi del ponte di San Francesco fu fatto segno a vari colpi di rivoltella. Colpito gravemente, potè reggersi in piede fino alla Piazza Grande ove cadde svenuto. Un altro socialista, Nicola Adamo, ch’era uscito da casa appena saputo il fatto nel quale un suo compagno era rimasto ferito gravemente, avvistato dai fascisti nei pressi della Piazza Piccola, venne raggiunto e bastonato a sangue. Per tutta la notte di domenica la città fu scorsa da un capo all’altro dalla banda vittoriosa e si procede all’arresto di alcuni…operai”.
Il giorno dopo, nonostante un maldestro tentativo di alibi, Nicola Zupi veniva arrestato. I due operai socialisti, ricoverati in ospedale, venivano piantonati per evitare nuove aggressioni.
Le condizioni di Paolo Cappello apparvero subito gravi. Morì alcuni giorni dopo per le conseguenze delle ferite riportate chiedendo di avere all’occhiello della giacca un garofano rosso. Nicola Adamo se la cavò non senza dolorosi strascichi con una lunga degenza in ospedale. I funerali furono imponenti, tutta la classe operaia di Cosenza vi partecipò, con alla testa l’intero gruppo dirigente socialista, comunista e repubblicano.
Il clima in città restava dunque incandescente e lo squadrismo era più attivo che mai: scritte “Viva Zupi” facevano la loro comparsa sui muri. Il processo sull’assassinio di Paolo Cappello si tenne a Castrovillari perché Cosenza veniva considerata una piazza “ostile”. Cito ancora le parole di Pietro Mancini, difensore di “parte civile”, come si direbbe oggi, insieme a Fausto Gullo, in quel processo: “rammento il processo e la istruttoria difficoltosa, nella quale tanti galantuomini calpestarono per viltà la propria coscienza. (…)Ho nelle orecchie le invettive volgari con le quali ‘gli eroi’ dalla gabbia salutavano l’apparire nell’aula di Fausto Gullo e di me (…). Vedo l’aula gremita di fascisti urlanti e indisturbati, il pubblico ministero venuto da Catanzaro, fraternizzare con i difensori, il Presidente Graziani scandalizzato e impotente, i giurati premuti ed insidiati; e poi il verdetto scandaloso e l’apoteosi degli assassini per le vie di Castrovillari”. Un processo farsa, quindi, con Mancini e Gullo costretti a rifugiarsi in una casa amica per evitare le rappresaglie degli imputati liberati e dei loro scherani.
Dopo la guerra e con il ritorno della democrazia gli imputati del processo rinunziarono alla pregiudiziale di innocenza per poter usufruire della amnistia di Togliatti.
QUESTIONE ROM: L’INTEGRAZIONE E’ UN DOVERE SIA PER CHI ARRIVA SIA PER CHI OSPITA.


Diciamoci la verità, per poco non ci è scappato il morto con l’incendio nel “villaggio” ROM sul fiume di Cosenza. Senza contare le condizioni vergognose in cui vivono le persone in quella “favela”, tra sporcizia, topi e il rischio continuo che il fiume se li porti via con un’ondata di piena improvvisa. Oggi apprendiamo del rifiuto dei 60 scampati all’incendio a trasferirsi nella ex scuola “Don Milani” e a voler restare lì, in quelle condizioni degradate. Tutto ciò ci pone di fronte alla domanda: può una città civile consentire che 500-600 persone vivano in quelle condizioni, a rischio della loro stessa incolumità fisica ? Può, nello stesso tempo, accettare la pervicace ostinazione a voler restare in quelle condizioni ? Si può legittimare questa ostinazione, spesso dettata da motivazioni ben poco nobili, con la costruzione di un villaggio (eco, temporaneo o a numero chiuso che sia) che nei fatti diventerà l’ennesimo ghetto ? Massimo Converso, presidente dell’Opera Nomadi, giustamente si batte contro questa soluzione. I villaggi di quel tipo legittimano solo l’evasione scolastica, la volontà di non essere censiti e di occultare attività spesso “utilizzate” come manovalanza a basso costo dalla malavita.
Dovunque l’integrazione è avvenuta quando culture si sono mescolate, tollerandosi ed accettandosi con quella ospite, rinunciando certo, a parte di sé ma per il supremo bene della convivenza e della sicurezza collettive. Il nostro ordinamento, ad esempio, non consente, giustamente, la poligamia o il burka, pur difendendo il diritto di tutti a professare la propria fede.
Se la nostra casa è pericolante e mette in pericolo la nostra sicurezza e quella degli altri il nostro ordinamento prevede, giustamente, l’evacuazione di quella casa anche in deroga al nostro diritto di proprietà su quell’immobile.
Sono regole elementari che tutti, nel nostro territorio, sono tenuti a rispettare. E se persisto nel volerle non rispettare posso essere, legittimamente, invitato ad andar via.
Nel 2007 il “villaggio” sul fiume Crati fu sgombrato e i suoi abitanti, grazie ad un’azione congiunta di Prefettura, Comune, Provincia e Curia furono trasferiti in case reperite (non senza difficoltà) dal Comune e nei comuni dell’hinterland. Non durò molto perché i rom abbandonarono le case e tornarono sul fiume, con alterchi e risse scoppiate tra coloro che volevano comunque accettare le soluzioni offerte e quelli che invece si ostinavano a restare nella baraccopoli. Ci fu anche una polemica, che coinvolse il sottoscritto, che ribadiva la bontà della scelta del 2007, e alcune cosiddette associazioni “antirazziste” che chiedevano l’allestimento di un villaggio perché i rom sono naturalmente “nomadi” e quindi naturalmente portati ad abitare in baracche. Fui preso a male parole anche quando criticai la cosiddetta “scuola del vento” messa in piedi da queste associazioni, una iniziativa che allestiva una scuola per i bambini nella baraccopoli mentre gli scuolabus del Comune continuavano a viaggiare vuoti, nonostante l’impegno degli amministratori e di alcuni dirigenti scolastici di allora di dotare alcuni istituti di una politica di accoglienza e persino di docce per dei bambini che, vivendo all’addiaccio, non potevano certamente essere al massimo dell’igiene (una decisione presa tra le proteste dei genitori dei bambini italiani che inscenarono vivaci manifestazioni). Ma questa è la strada dell’integrazione, difficile, ma senza alternative.
Sarò antico, potrò non essere un esperto di antropologia, ma io continuo a pensare che vivere in una baracca in campi-ghetto, anche se dotati di minimi servizi essenziali, non possa essere un esempio di integrazione. Continuo a pensare che l’integrazione scolastica si svolga nelle scuole, mettendo insieme bambini di diversa cultura ed etnia e sia inaccettabile che possano esistere scuole diverse per bambini diversi. Io continuo a credere che abbia ragione Massimo Converso quando propone di persistere sulla soluzione del 2007 e a rifiutare la logica dei ghetti. Perché a nessuno è consentito di rifiutare le regole del posto in cui vive e pretendere la legittimazione di una illegittimità. Perché integrarsi è un dovere sia per chi arriva sia per chi ospita, sempre.
Per un pugno di voti il Molise rimane al centrodestra. Per il PD resta aperto il problema delle alleanze.

In Molise con il 46,94 % il candidato del centrodestra Angelo Michele Iorio si conferma per la terza volta alla guida della piccola regione seguito con il 46,15 % dal candidato del centrosinistra Paolo Di Laura Frattura. Uno scarto in termini assoluti di appena 1500 voti.
Dita puntate su Grillo che con il suo 5,6% avrebbe impedito al centrosinistra di vincere. Franceschini li accusa di aver fatto vincere “un inquisito”.
Ora, francamente io credo che dare la colpa a Grillo di non essersi alleato con il centrosinistra in nome dell’antiberlusconismo sia un grave errore politico. Intanto perché è davvero singolare pensare che Grillo e il suo movimento che interpreta pienamente e coerentemente l’antipolitica italiana possa essere suscettibile di un’alleanza di governo, anche a livello locale.
Pensare a Grillo come l’ennesimo partito o movimento del centrosinistra da aggregare nel “Fronte popolare anti-Berlusconi” è la rappresentazione del limite profondo che ancora pervade la strategia delle alleanze di governo del PD. Primo perché Berlusconi, nonostante le fiducie, non è eterno e secondo perché un’alleanza siffatta, pur vincente, non sarebbe in grado di governare (l’esperienza dell’Unione sta ancora lì, tutta, a ricordarci il limite di quella politica e che ci spinse, giustamente, a dare vita al PD).
La strutturazione del Centrosinistra di Vasto, PD+IDV+SEL non è sufficiente non solo numericamente, ma politicamente.
Tenere insieme chi propone il ritorno alla legge Reale dopo i fatti di Roma con chi fino a ieri dichiarava che Carlo Giuliani era un eroe è un’operazione che non ha la minima credibilità e quando si andrà a votare non potrà non emergere e anche se si vincesse non potrebbe non pesare.
Di Pietro, che qui ha eletto il suo “Trota” consigliere regionale è un populista che in qualunque democrazia “normale” troverebbe la sua naturale collocazione nella destra, magari in quella cosiddetta “sociale” che nel Parlamento europeo raggruppa gli esponenti di Jean Marie Le Pen o i post-falangisti spagnoli.
Un’altra contraddizione è costituita da Vendola e da SEL, che si configura come una riedizione, neppure tanto nuova, del PRC bertinottiano. La notizia riportata oggi dal Corriere della Sera secondo la quale SEL avrebbe mediato con il “movimento” per un certo tipo di corteo in cambio di candidature tipo quelle che portarono i no global Caruso e Agnoletto nelle tanto bistrattate ma allo stesso tempo tanto spasmodicamente cercate istituzioni “borghesi”, se vera, rileva una difficoltà di fondo per Vendola di staccarsi da un retaggio politico caratterizzato da un antagonismo marginale e comunque assolutamente incompatibile con il profilo e la funzione di una sinistra moderna che si candida addirittura a guidare un grande Paese europeo come l’Italia.
Se poi guardiamo ai risultati delle liste balza subito agli occhi la buona affermazione dei socialisti, che passano dal 3 al 5 % (superando i grillini che come liste arrivano appena al 3 % e non conquistano neppure un seggio), il 9 % del PD (pochino) e l’altrettanto deludente risultato di Di Pietro (8,37%), che nella sua regione, con il figlio candidato perde in voti (quasi 2000) e percentuale. SEL e Rifondazione Comunista insieme superano di poco il 6%. Nell’altro campo l’UDEUR oggi alleata con il centrodestra e l’UDC più altre formazioni di centro superano abbondantemente il 15 % senza contare alcune civiche riferibili più o meno al Terzo Polo.
Le indicazioni elettorali sono quindi assai chiare e dovrebbero consolidare una strategie delle alleanze del PD diversa, in cui inclusioni ed autoesclusioni siano fatte sulla politica e non sul richiamo ad un frontismo parolaio e massimalista. Pensare che la questione si possa risolvere includendo un altro parolaio e massimalista a quelli che già affollano l’attuale centrosinistra non solo è sbagliato ma criminale.
Il diritto all’odio non esiste…

Dopo l’episodio di Milano con il lancio della statuetta in faccia a Berlusconi nel 2009, Marco Travaglio scrisse sul blog di Beppe Grillo un articolo con il quale parlava di “diritto all’odio”. Il giornalista di destra diventato icona di certa sinistra forcaiola scriveva: “Chi l’ha detto che non posso odiare un politico e augurarmi che il Creatore se lo porti via al più presto? Un politico si vota, non si ama. In politica non esiste l’amore, non c’è sentimento”. E ancora. «Non vedo per quale motivo – continuava l’ex giornalista de “Il Borghese” – qualcuno non possa odiare Berlusconi. L’importante è che si limiti ad odiarlo senza fargli nulla di male”.
Ora io credo che questa affermazione sia rivelatrice di un vero e proprio veleno che si è diffuso nella politica e nella società italiana, in una parte delle sue classi dirigenti, della cultura e della cosiddetta “intellighenzia” radical italiana, un veleno che va combattuto con decisione e senza tentennamenti.
La realtà sociale del Paese è infatti drammatica. Interi pezzi di società sono sospinti sotto la soglia della povertà, diritti che si credevano acquisiti vengono di giorno in giorno negati e fatti a pezzi.
In questo contesto la politica e le classi dirigenti nel loro complesso devono assumersi la responsabilità di indicare soluzioni non di soffiare sul fuoco o versarvi benzina.
Non esiste il “diritto all’odio” perché l’odio è la negazione di ogni diritto. Chi fomenta l’odio, anche quando non si rende colpevole di violenze, e soprattutto se lo fa dall’alto della sua condizione di “privilegiato” da decine di migliaia di euro al mese (spesso molto di più dei tanti bistrattati politici) che gioca sulla disperazione di tanti, diventa colpevole indiretto delle violenze che da quell’odio inevitabilmente si generano.
In Italia è già successo, purtroppo, e i rischi che tutto si ripeta ci sono tutti come dimostrano i fatti di Roma. Non si tratta di ripercorrere la categoria dei “cattivi maestri”, di invocare censure, ma di avviare una campagna politica e culturale contro chi irresponsabilmente si fa promotore di una visione manichea e distruttiva della politica dal tepore dei salotti o per il gusto della tirata demagogica nei talk show televisivi, una visione che distrugge la democrazia nei suoi stessi principi fondativi.
Io trovo significativo che i manifestanti pacifici sabato abbiano cercato di espellere quelli violenti dal corteo. E’ un fatto importante che, a mia memoria, non era mai successo. Segno che gli anticorpi ci sono e vanno incoraggiati e moltiplicati. Avendo il coraggio di contestare a gente come Travaglio e a tanti altri come lui le innumerevoli e irresponsabili parole che assai spesso propagano a piene mani.
Perché nessun dissenso, per quanto profondo e radicale esso sia, può giustificare l’odio politico. Perché la democrazia è nata proprio per regolare i conflitti e bandire l’odio dai rapporti civili e politici e non il contrario, altro che balle.